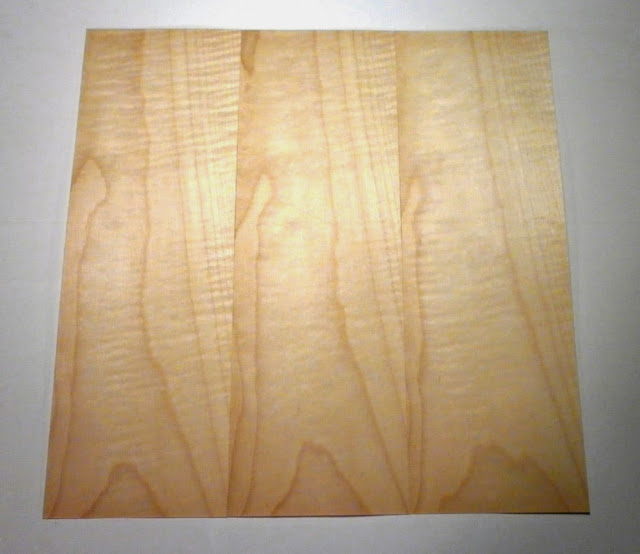Dopo che abbiamo
impiallacciato e squadrato un pannello ci ritroviamo con un elemento che non è
rivestito di legno dappertutto; infatti sono rimasti scoperti i bordi. Per
rivestire anche questi con lo stesso legno, i sistemi sono diversi: se si hanno
delle conoscenze in una falegnameria, si può andare a chiedere un certo
quantitativo di bordo da un millimetro di spessore e della larghezza adeguata.
Nel caso che ci debba
preparare anche il bordo, si può procedere incollando tra i piani che abbiamo
adoperato per il placcaggio del pannello, due fogli di impiallacciatura, facendo
attenzione a non sovrapporli esattamente.
L’operazione va fatta
invertendone uno, per fare in modo che le venature del legno si incrocino, come
si vede dalla foto seguente.
Questa procedura ci
permetterà di non avere screpolature, che invece si possono verificare se le
tensioni dei fogli di tranciato sono rigorosamente sovrapposte; una volta
incollati i due fogli, possiamo procedere a tagliarli della giusta larghezza
utilizzando la sega circolare, avendo l’accortezza di mantenere un pannellino
sotto i fogli per evitare sbrecciature.
Quando parlo di
“larghezza adeguata” intendo una dimensione che sia superiore di circa 4 mm.
rispetto allo spessore del pannello che dobbiamo bordare; per esempio: se siamo
partiti da un pannello di multistrati di 18 mm., con il placcaggio è diventato
circa 19 mm., pertanto il bordo che ci serve deve essere di 23 o 24 mm. di
larghezza.
Questo margine ci
garantisce di fare un buon lavoro perché il sistema di bordatura, qualunque
esso sia, prevede che si debba avere una certa abbondanza durante
l’applicazione del bordo, per rivestire con certezza lo spessore del pannello
durante l’operazione di bordatura. Ecco come si presentano i bordi ottenuti dai
due fogli incollati precedentemente (ne è stato fatto uno di scorta).
Escludendo di usare
una bordatrice, che è un’apparecchiatura presente solo nelle falegnamerie, noi
dobbiamo accontentarci di sistemi manuali, che richiedono più tempo, ma che
danno comunque un buon risultato.
I bordi possono essere
applicati con la colla vinilica, che viene spalmata sui bordi (prima si procede
con i lati corti, poi con i lunghi) che vengono poi premuti sul pannello usando
contemporaneamente due righetti per distribuire la pressione dei morsetti.
Bisogna stare attenti
continuamente alla posizione mentre si stringe, perché ci deve garantire una
copertura completa e la colla vinilica rende i bordi scivolosi; ricordiamoci
che i bordi devono risultare anche più lunghi del lato del pannello che devono
rivestire.
Questo metodo, oltre
ad essere il più scomodo, ha anche un altro aspetto negativo che è il tempo di
essicazione, il quale si aggira mediamente attorno all’ora e mezza; siamo
quindi costretti ad aspettare tutto questo tempo prima di passare alla
bordatura dei lati lunghi.
Invece si può adottare
un sistema veloce se si usa una colla neoprenica a contatto (tipo Bostik, tanto
per intenderci), che in questo caso va spalmata su entrambe le parti da fare
aderire, usando una spatola dentellata per garantire la giusta distribuzione
della colla.
Una volta che questa
sembra essersi asciugata, cioè dopo circa 10/15 minuti, i bordi vanno accostati
alle teste del pannello; l’applicazione va fatta con molta attenzione per non
rischiare di metterli fuori asse, correndo il rischio di andare fuori dal
percorso stabilito.
Questa colla non
permette sbagli: se partite inclinati non riuscirete a coprire tutta la testa
del pannello e non si può cercare di tirare via il bordo applicato storto per
cercare di riposizionarlo perché si romperebbe; quindi è meglio fare un po’ di
pratica per imparare a tenere il bordo allineato col pannello, mentre lo si
sistema al suo posto.
Terminata
l’applicazione bisogna premerlo con forza, usando un oggetto arrotondato (basta
un righetto di legno duro a cui si è arrotondata un’estremità), oppure bisogna
batterlo, tenendo il pannello verticale, usando un martello e frapponendo un
blocchetto di legno che si fa scorrere per tutta la lunghezza del bordo, durante
la percussione.